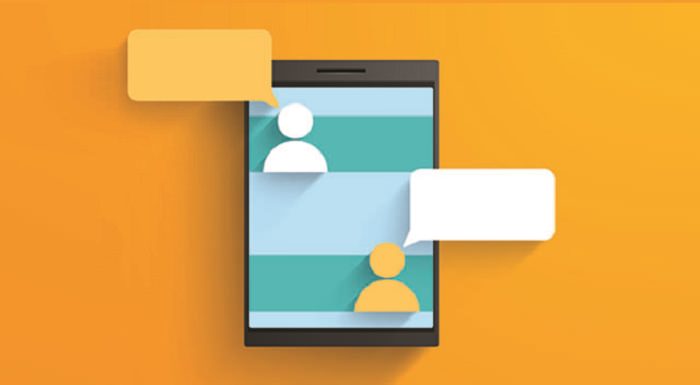 Il costante aumento di immigrati nella società esige una ridefinizione delle strutture politiche e sociali e, mentre il mondo si globalizza, le diversità si confrontano e si scontrano. Fino a pochi decenni fa si viveva una certa omogeneità linguistica, culturale e religiosa. Oggi invece ci si trova di fronte a classi multiculturali per le quali è necessaria una educazione interculturale; che cosa significano veramente questi due aggettivi?
Il costante aumento di immigrati nella società esige una ridefinizione delle strutture politiche e sociali e, mentre il mondo si globalizza, le diversità si confrontano e si scontrano. Fino a pochi decenni fa si viveva una certa omogeneità linguistica, culturale e religiosa. Oggi invece ci si trova di fronte a classi multiculturali per le quali è necessaria una educazione interculturale; che cosa significano veramente questi due aggettivi?
I due termini apparentemente uguali vengono spesso considerati sinonimi, ma in realtà tra i due concetti esiste la stessa differenza che c’è tra leggere un libro di avventura e vivere l’avventura in prima persona.
È un dato di fatto che le nostre città, le nostre scuole e le nostre chiese sono sempre più “colorate”; dire perciò che viviamo in una società multi-culturale è una constatazione evidente. Negare questo è negare la realtà.
A ben guardare la società multiculturale manifesta spesso un forte etnocentrismo; il gruppo dominante, perché più numeroso, sostiene l’omologazione al proprio modello e cerca di assimilare le differenze fino a rendere invisibile ogni manifestazione di alterità, di differenza. In questo caso il contatto fra le varie etnie spesso si risolve in conflitto piuttosto che in dialogo perché in un gruppo emerge il desiderio di non soccombere.
Al contrario, nelle società interculturali il gruppo più grande è il gruppo accogliente che individua e promuove strategie di incontro fra le culture in modo da creare occasioni positive di conoscenza reciproca e di valorizzazione delle differenze. Questi sono i concetti-chiave che vengono analizzati nell’educazione interculturale.
È evidente che una Chiesa attenta ai cambiamenti non può non tener conto di questa mutata realtà, che è destinata ad incidere sulla personalità delle future generazioni. Senza cadere nella banalizzazione o folklorizzazione delle culture “altre” è necessario che la Chiesa che si avvia in questa direzione si prepari adeguatamente, altrimenti rischia di fermarsi agli stereotipi dei titoli dei giornali o al contrario agli immaginari idealistici delle agenzie turistiche.
Multiculturale è quella comunità (nazionale, scolastica, sociale, religiosa) in cui sono presenti più popoli o etnie che tuttavia rimangono separati fra di loro, ognuno nella propria zona fisica e culturale e che raramente entrano in contatto.
Interculturale definisce invece un contesto relazionale in cui i vari gruppi linguistici e culturali stabiliscono fra di loro un costante rapporto dialettico di arricchimento reciproco fondato sul mutuo rispetto, sull’interesse per ciò che l’altro rappresenta o può rappresentare.
La multiculturalità è un fatto oggettivo non contestabile, non altro che la trascrizione oggettiva di una realtà di fatto, una semplice registrazione della compresenza su uno stesso territorio di diversi popoli, etnie, lingue, valori: altra cosa è l’educazione interculturale. Il termine intercultura ha una valenza progettuale: rinvia ad un impegno comune che ha come fine l’incontro attivo tra soggetti portatori di culture differenti aperti al dialogo, disposti a modificare e a farsi modificare. L’intercultura è orientata all’arricchimento reciproco finalizzato alla convivenza pacifica e alla ricerca collettiva di soluzioni appropriate per far fronte alle difficoltà del multiculturalismo.
L’interculturalità è una risposta educativa, è l’intenzione di entrare in questo mondo “altro”. È il desiderio di farsi conoscere dall’altro e di conoscerlo meglio, visto che camminiamo sullo stesso marciapiede, abitiamo nello stesso condominio, viviamo nella stessa comunità, frequentiamo la stessa scuola e siamo membri della stessa chiesa. Essendo perciò un fatto intenzionale, l’educazione interculturale si basa certo sulla conoscenza delle culture altre, ma a partire dalle persone che conosco e frequento, le persone prossime a me. L’educazione interculturale non è una materia da studiare, ma un atteggiamento da vivere. In questo senso fare educazione interculturale è, da sempre, compito della scuola, degli insegnanti, della politica ma è soprattutto un impegno da assumere tutti con consapevolezza per superare le differenze individuali e giungere, dove possibile, ad una sintesi.
È in questa prospettiva che guardo al compito della chiesa, che potremmo definire “agenzia educativa privilegiata”. Compito che emerge fondamentale nella formazione di credenti in grado di vivere in armonia con la Parola di Dio e interagire positivamente in una chiesa multiculturale, che proprio per questo deve proporre un’educazione interculturale.
La chiesa si trova in una posizione cruciale proprio perché rappresenta uno dei più importanti crocevia di razze e culture del nostro mondo ed è chiamata quotidianamente a sciogliere “emergenze relazionali” che spesso sono risolte solo grazie alla buona volontà di pastori o credenti aperti e pronti alla mediazione.
Non proponiamo ricette magiche, ma, mettendo in pratica la Parola di Dio ci apriamo a nuovi sistemi culturali e ci prepariamo all’incontro con l’altro, con il diverso da noi, disponendoci ad assumere un atteggiamento di apertura che sarà indispensabile per stabilire l’atmosfera più appropriata all’interno della comunità o gruppo in cui ci si trova ad operare.
Il mandato di Gesù: “Andate in tutto il mondo e predicate l’evangelo ad ogni creatura” è oggi più che mai attuale e alla portata di ogni credente. Il mondo oggi non è lontano come ieri. Chiunque in tempo reale, da ogni parte del mondo può incontrare nella sua quotidianità una varietà di culture. In casa nostra, sul posto di lavoro, in comunità, al supermercato dove facciamo spesa, sul web, in ogni luogo reale o virtuale, noi siamo a contatto con il mondo.
I modi di vivere e le abitudini di consumo vengono modificati da elementi provenienti dalle culture degli immigrati o subculture presenti nelle città. I quartieri arabi, i ristoranti e negozi cinesi, la musica, sono alcuni esempi della multi-cultura urbana.
La globalizzazione rischia di accentuare in termini problematici tale “diversità nell’unità”: Da un lato si impone la spinta verso forme di maggiore omologazione e dall’altro si fa spazio all’esaltazione della peculiarità delle differenti culture.
Naturalmente i principali insegnanti di una educazione all’accoglienza dell’altro sono i genitori, responsabili naturali dell’educazione dei figli, nonché la scuola; ma un ruolo importante è affidato anche alla chiesa, che ha il dovere di aprirsi al dialogo e all’accoglienza di ogni persona, non importa di quale cultura, lingua o nazione, che si accosti a Dio (Galati 3:26-29).
Nella Bibbia la chiesa nascente è monoculturale (Giovanni 20:22), ma in pochi giorni diventerà multiculturale (Atti 2) e dovrà affrontare sfide enormi al suo interno, che provocheranno tensioni: le vedove e gli orfani ellenisti (Atti 6); la Conferenza di Gerusalemme (Atti 15); i viaggi di Paolo attraverso nazioni, popoli e culture diverse allo scopo di guadagnare tutti all’Evangelo (I Corinzi 9:19).
La sfida della chiesa sarà sempre quella di rimanere fedele all’insegnamento biblico nel rispetto delle culture diverse che abbracciano l’Evangelo. Questo è un processo interculturale. Ma l’attenzione alla dimensione interculturale non è scontata nelle chiese. Come stiamo affrontando l’emergenza dei flussi migratori? Siamo pronti ad accogliere i credenti provenienti da altre nazioni, da ambienti culturali diversi? Oggi più di ieri è richiesta in questo ambito una fedeltà coraggiosa ed innovativa al modello biblico.
Nel capitolo 14 e 15 dell’epistola ai Romani, l’apostolo delle genti indica la condotta da tenere verso il prossimo nell’ambito cristiano. In particolare, dà dei consigli per gestire le nostre preoccupazioni su cose di importanza secondaria, rispetto alle quali sembra ci fossero delle lacune tra i cristiani di Roma. Si tratta di consigli che contribuiscono a preservare l’amore cristiano. Sicuramente non c’è nulla di più pericoloso e spesso disastroso nelle chiese, delle dispute e delle divisioni tra i propri membri. Sono ferite che uccidono l’anima e la vita dello spirito. Qui Paolo come un abile medico fornisce il balsamo spirituale per la guarigione di ogni intolleranza e controversia: personalmente credo che se questi consigli biblici venissero compresi e vissuti, risanerebbero tanti cuori nelle nostre chiese, ancora oggi.
Questi versi sono un’esortazione alla tolleranza e all’accoglienza:
“tolleranza” termine culturale, sociologico e religioso indica la capacità individuale e collettiva di vivere con coloro che credono e agiscono in maniera diversa dalla propria. In questo caso indica il “prendersi a carico”, così come Paolo si esprime in Galati incoraggiando a “portare i pesi gli uni degli altri”.
“accoglienza” deriva da “cogliere, raccogliere”[far entrare, ricevere, ammettere in un gruppo] accettare, alloggiare, dare asilo, ospitare, ricevere. È il contrario di allontanare, congedare, licenziare, mandare via, cacciare, sbattere fuori.
Perché Paolo è costretto a parlare di accoglienza nella chiesa?
Perché ieri come oggi le chiese sono costituite da persone che provengono da paesi, lingue e culture diverse o più semplicemente da vissuti diversi e ognuno porta dietro di sé abitudini, usi e costumi propri. La chiesa di Roma, ad esempio, era costituita da giudei e pagani convertiti a Cristo. I giudei legati alle prescrizioni mosaiche così difficili da estirpare, per paura di trasgredire la legge e contaminarsi, mostravano una fede debole; erano pieni di scrupoli riguardo ai giorni da santificare, ai cibi da mangiare e ad altri dettagli della Legge. Gli altri i gentili, si erano finalmente scrollati di dosso tutti i riti pagani e, non avendo più scrupoli di coscienza, godevano della libertà che avevano trovato in Cristo. Questa “libertà” preoccupava i giudei e si rischiava che gli scrupoli sfociassero in dispute. Così Paolo è costretto a ricordare a questi credenti l’importanza della mutua tolleranza e della vera accoglienza.
Estremamente premuroso e pieno d’amore per tutti, l’apostolo Paolo suggerisce ai credenti di Roma, cosi come ai credenti di Corinto e della Galazia, che “chi è forte nella fede non deve disprezzare chi è debole; né chi è debole deve giudicare chi non lo è”. Accoglierci gli uni gli altri è ciò che Cristo insegna e che gli apostoli ripetono nelle epistole. L’accoglienza è un importante insegnamento biblico! Accoglierci sì, ma… accoglierci come?
ACCOGLIERCI PER QUELLI CHE SIAMO
“Accogliete il debole, ma non per sentenziare sugli scrupoli degli altri… non per discutere opinioni”. Chi è debole nella fede deve essere accolto (letteralmente: portatelo a voi, dategli il benvenuto, porgetegli la mano, ricevetelo con affetto e premura). Non lasciate che la comunione cristiana sia intaccata da inutili dispute di parole. Paolo esorta all’accoglienza e non alla sentenza (“accogliete il debole, ma non per sentenziare”); al rispetto e non al disprezzo (“tu perché disprezzi?”); alla stima e non al giudizio (“tu perché giudichi?”).
Tutti i credenti, che abbiano una fede debole o una fede forte, sono la nostra famiglia, i nostri fratelli. Pensiamoci… troppo spesso con ignoranza e arroganza, usurpiamo il trono di Dio quando ci ergiamo a maestri dei nostri fratelli e pretendiamo di poter giudicare i loro pensieri e le loro intenzioni, finanche i loro sentimenti. Ma Dio non vede come vede l’uomo; quando giudichiamo i nostri fratelli ci intromettiamo in ciò che non ci compete! Non c’è niente di più negativo che costringere il vero cristianesimo in consuetudini o in formalismi. In questo modo finiamo per corroderne l’essenza. La forma non può sostituire la sostanza. Che cos’è la sostanza? È la Parola di Dio, è “quello che è scritto e non oltre quello che è scritto”. La forma invece è ciò che contiene e veicola la sostanza. La forma può mutare, si può trasformare per gli usi e i costumi diversi, o per il tempo; per essere più adeguata ed efficace all’epoca in cui si vive. La sostanza invece non cambia perché Dio è sempre lo stesso e la Sua “Parola sussiste in eterno”.
Le forme possono cambiare, ma nella libertà di opinione e nel rispetto reciproco deve crescere la comunione. Le critiche turbano la comunione, mentre l’amore la edifica, la costruisce e la conserva… “Cerchiamo, dunque, di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione” (v.19).
ACCOGLIERCI NONOSTANTE LE DIVERSITÀ
Le diversità culturali rappresentano in verità una ricchezza e vanno comprese come espressione della fondamentale unità del genere umano, tanto più del Corpo di Cristo (I Corinzi 12:12-27).
La diversità può dividere o arricchire, dipende dal modo in cui la vediamo e la viviamo. Dobbiamo imparare a scoprire la ricchezza che c’è nella diversità. Il corpo di Cristo è uno e unico nella sua varietà. “Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l’uno dell’altro” (Romani 12:4,5). Siamo chiamati a valorizzare l’UNICITÀ (un solo e unico corpo), la VARIETÀ (tante membra), la DIVERSITÀ (ognuna diversa dall’altra), la SPECIFICITÀ (ognuna la sua funzione) e l’UNITA’ (tutte membra l’una e l’altra) del corpo di Cristo.
ACCOGLIERCI COME CRISTO CI HA ACCOLTI
“Non perdere con il tuo cibo, colui per il quale Cristo è morto”; “Non distruggere per un cibo l’opera di Dio”; “Non essere occasione di caduta per il tuo fratello”. “Or noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene, a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso; ma come è scritto: “Gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me».
Dobbiamo porre molta attenzione a non fare nulla che tenda a disfare l’opera di Dio, perché per quest’opera… Cristo è morto. Gesù ha sopportato le più grandi infamie per dar vita alla Chiesa. Ogni peccato che compiamo è come un insulto a Dio. Non siamo chiamati a compiacere noi stessi, perché Cristo non ha compiaciuto se stesso: “Egli non considerò l’essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, si umiliò fino alla morte”.
ACCOGLIERCI PER LA GLORIA DI DIO
“Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di aver tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e d’una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio”.
C’è molto da imparare dalle Scritture e il migliore ammaestramento è quello che si trae da queste fonti. Senza la pazienza non ci può essere consolazione. Accogliere, ricevere chi non è proprio come noi può sembrare fonte di sofferenza, ma può anche diventare fonte di consolazione e speranza.
Il metodo e la cura perché le differenze non generino diffidenze e poi si trasformino in divergenze rimane sempre lo stesso; un grande uomo di Dio del passato si espresse così: “Nella teologia, ci sia unità, nella metodologia ci sia libertà e su tutto carità”.
Luca Marino | Assembleedidio.org
Sostieni la redazione di Notizie Cristiane con una donazione, clicca qui
























