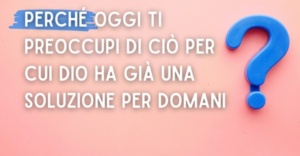In questo mondo c’è ancora chi non ha capito che essere una persona autorevole, famosa o eccezionale nel suo lavoro non significa essere Dio sulla terra. Da 10 anni leggiamo gli interventi rilasciati ai media dall’oncologo Umberto Veronesi ed il più delle volte non comprendiamo il punto di partenza e il punto di arrivo…insomma, non condividiamo quasi nulla!Nel giugno del 2011, l’illustre oncologo Umberto Veronesi entro in merito alle coppie gay: «Quello omosessuale è l’amore più puro, al contrario di quello eterosessuale, strumentale alla riproduzione». Così l’oncologo ed ex ministro della Sanità, Umberto Veronesi, rispose alle polemiche scatenate in quei giorni dalle dichiarazioni del sindaco di Bologna, Virginio Merola, e a quelle del sindaco di Sulmona, Fabio Federico. Federico aveva equiparato certi tipi di omosessualità ad una «aberrazione sessuale», mentre Merola aveva lanciato un’iniziativa per la tutela «delle coppie sposate» a dispetto di quelle di fatto, omosessuali comprese. «Io, come potete immaginare – disse Veronesi, a margine di una conferenza per presentare la sua iniziativa “The future of science” – la penso all’opposto: l’omosessualità è una scelta consapevole e più evoluta. L’amore omosessuale è quello più puro»; in quello eterosessuale, invece, una persona direbbe «io ti amo non perché amo te, ma perché in te ho trovato la persona con cui fare un figlio. Nell’amore omosessuale invece non accade: si dicono “amo te perché mi sei vicino, il tuo pensiero, la tua sensibilità e i sentimenti sono più vicini ai miei”. Se come dice l’oncologo l’amore omosessuale non è strumentale alla riproduzione, le persone che vivono questo tipo di situazione non dovrebbero nemmeno desiderare di avere dei figli da allevare (la riproduzione comporta alcune conseguenze). Le richieste di consentire l’adozione e coppie omosessuali mi pare dicano il contrario.
Ascoltando Veronesi si potrebbe dormire tranquillamente sopra i contenitori di scorie radioattive e girare sicuri con l’uranio impoverito in tasca, che non ne avremmo nessun danno. Senza contare le uscite sulle diete vegan e simili. Ora ci mancava anche questa linea pro gay, dopo che era arrivato anche ad affermare che l’uomo raggiunti i 65 anni non ha più utilità (da notare che lui ha superato gli 80) più tante altre sparate tirando in ballo persino i disabili e la sua idea del “sesso virtuale” del futuro. Senza considerare poi la sua rinomata industria di morte: prima creo il cancro poi guadagno sulle “cure”.
Ma non è tutto l’oncologo già dieci anni fa’, per l’esattezza, il 4 novembre del 2003, c’aveva stupito con un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, dove aveva rilasciato una lunga intervista incentrata sui temi fondamentali della vita, del dolore, della morte. Devo confessare che leggendola mi è venuto spontaneo soffermarmi su alcune affermazioni importanti del Professore sul rapporto tra dolore/morte e fede e sul ruolo della scienza in questo campo, perché toccano problemi esistenziali che interessano tutti da vicino e che portano ben oltre il sapere. Innanzitutto Veronesi rovescia la tesi di un Giobbe paziente sostenendo: «Giobbe non accetta la sofferenza ingiusta, l’imperscrutabilità del potere divino.
Vi si ribella e Dio non lo condanna». Tesi molto ardita, perché se è vero che Dio critica gli amici presuntuosi che vorrebbero costringere Giobbe a riconoscere colpe che non ha, è altrettanto vero che rimprovera Giobbe per la pretesa appunto di conoscere i misteri di Dio e della vita: «Dov’eri tu quand’io ponevo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta intelligenza!» (38,4). E alla fine Giobbe si pente e ritratta le sue lamentele: «Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Perciò mi ricredo e ne provo pentimento su polvere e cenere» ( 42, 5–6).
Sostiene poi Veronesi: «La sofferenza è stata considerata per secoli una forma purificatrice, un fattore di redenzione. Osservare per una vita la sofferenza degli altri, però, mi ha condotto alla conclusione opposta. Il dolore allontana da Dio. Il malato terminale è del tutto concentrato su se stesso. Il male lo induce a dimenticare il bisogno della divinità, lo distrae, lo impegna in ogni momento. È un cattivo consigliere. Va prevenuto, lenito con ogni mezzo disponibile, se possibile sconfitto. E la premessa di questa battaglia è ripristinare il primato della ragione».
In effetti nella cultura cattolica ci sono state, e ci sono tuttora, tendenze che esaltando la forza purificatrice della sofferenza scavalcano facilmente l’ostacolo di un peso a volte insopportabile, soprattutto quando si abbatte improvviso, alla faccia di tutte le prevenzioni e le ragioni di questo mondo. L’atteggiamento che, per un cristiano, riconduce alla fonte del mistero è quello di Gesù nell’orto degli ulivi. Matteo gli fa prima dire: «Una tristezza mortale mi opprime», e poi gli mette sulla bocca queste parole: «Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice di dolore! Però non si faccia come voglio io, ma come vuoi tu». E lo ripeterà una seconda volta, dopo aver scoperto che gli apostoli più vicini dormivano (26, 38–42).
Tuttavia appare davvero provocatoria l’idea che il dolore allontani da Dio e che l’unica via per difendersi sia la ragione. Anche perché l’intervistatore scrive: «Racconta– sempre Veronesi –di non ritenere che la morte sia un passaggio più lieve per i credenti; di aver avuto a volte l’impressione contraria, che i non credenti siano i più preparati alla fine, i più consapevoli del dovere di cedere il posto alle nuove vite».
Sarebbe interessante poter conoscere i dati concreti che permettono a Veronesi di sostenere queste tesi che a me sembrano, sinceramente, dovute a una forzatura, nel tentativo di giustificare l’esaltazione della ragione e l’esigenza di un nuovo illuminismo. Peraltro il problema non è rappresentato da un’improponibile e assurda gara tra credenti e non credenti per stabilire chi muore meglio o peggio. Il dramma è tutto nell’incontro–scontro tra la vita e la morte. Che sia un dramma lo conferma ancora Gesù Cristo con il suo grido sulla croce: «Dio mio, Dio mio per-
ché mi hai abbandonato» (Matteo 27,46). Quindi è vero che il dolore e la morte possono generare un durissimo faccia a faccia con Dio, fino alle soglie di un disperato senso di abbandono.
La stessa condizione di dolore lancinante, per l’invasività di una malattia crudele, per la perdita
di una persona amata, per gli sconforti mortali di qualsiasi genere, possono apparire insopportabili, quali che siano le convinzioni personali, religiose o no, di chi soffre. Ma si può affermare con sicurezza che la ragione non è e non può essere la via d’uscita. Perché i dolori più grandi
sono quelli irragionevoli, senza senso, come è capitato a Giobbe, figura emblematica di tutti i
sofferenti innocenti. Che può dire la ragione di tutte le stragi di innocenti, dalla prima consumata alle ultime, condensabili in una parola insensata, Auschwitz? Che può dire la ragione della capacità dell’uomo di essere disumano?
Questi interrogativi ci portano al centro del problema: il dolore e la morte sono parte di un mistero insondabile che nessuno è in grado di decifrare. Coloro che sostengono il contrario, con
o senza Dio, mentono a se stessi e agli altri. È questo uno dei tanti aspetti esistenziali sui quali si può pacificamente affermare che non c’è bisogno di alcun nuovo illuminismo perché quello vecchio non ha saputo illuminare alcun’ché, perché è un compito superiore alle forze dell’uomo.
Questo modo di pensare non induce affatto all’accettazione passiva, e tanto meno al masochismo, di fronte al dolore e alla morte: un cristiano combatte con tutte le sue forze contro il dolore e la morte, soprattutto a favore degli altri, invocando come Gesù l’allontanamento di un calice
tanto amaro: poi, se la grazia lo accompagna, accetta la volontà imperscrutabile di Dio. È un atteggiamento irrazionale? Se si deifica la ragione umana, certamente la fede in Dio porta oltre
e altrove, ma non per un rifiuto di tutte le risorse della ragione, bensì per intrinseca incapacità della ragione di districare l’intreccio tra dolore, male, morte.
Del resto quando si pensa che la cura del dolore o l’approccio alla morte possano essere questioni risolvibili sul piano umano, si imbocca la strada della presunzione come quella che fa dire a Veronesi: «Il medico esercita una sorta di potere magico sul paziente. Può alleviare, oltre alla sofferenza del corpo, quella della psiche». Per molteplici esperienze personali, dirette e indirette, mi sento di dire con forza che non serve un medico demiurgo, salvatore del mondo; basta e avanza un medico capace di ascoltare ogni malato per capire nel profondo la verità della malattia della persona singola (non del malato standard di una malattia codificata); basta e avanza un medico capace di trasmettere al malato la sensazione che avrà tutto l’aiuto necessario e possibile, perché per i miracoli ci pensa il Signore Gesù Cristo. A partire da qui ci sarebbero tante cose da dire sulla realtà quotidiana dei rapporti tra medici e malati; non quelli dei libri dei sogni di Veronesi, ma quelli della sofferenza aggiunta provocata proprio da chi dovrebbe alleviarla.
Ti è piaciuto l'articolo? Sostienici con un "Mi Piace" qui sotto nella nostra pagina Facebook