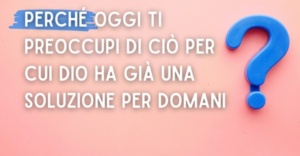Già nel 1995 Robert Fisk, probabilmente il più famoso corrispondente estero britannico, sull’Independent riportava casi come quello diFelixberta Pasco, cameriera filippina di 32 anni, corsa a chiedere aiuto alla propria ambasciata di Abu Dhabi dopo che il suo datore di lavoro l’aveva picchiata. Non si trattava di un caso isolato e non a tutte è andata “bene” come alla Pasco. L’ultima è morta. Si chiamava Khadija Kamel, era un’etiope poco più che ventenne, cameriera presso una famiglia a Dubai. Chiusa a chiave in uno stanzino per due mesi, torturata, denutrita, picchiata con un bastone dalla sua padrona e poi colpita da polmonite senza che le venisse prestato alcun soccorso. È morta così, l’autunno scorso, l’ennesima schiava moderna del Golfo Persico. La sua padrona, caso più unico che raro, è stata condannata a una pena esemplare: 15 anni di carcere, più tre per il marito, accusato di favoreggiamento. In una regione che incarcera e condanna a morte frotte di collaboratrici domestiche immigrate, colpevoli di essersi ribellate agli abusi e archivia le accuse mosse verso i propri cittadini, la condanna di un datore di lavoro rappresenta un barlume di speranza. Ma la strada per il pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori e di quelli umani è ancora lunga. “Sono milioni questi migranti e hanno zero diritti: spesso vengono uccisi o si suicidano” ha spiegato Human Rights Watch (Hwr) tracciando lo scorso 18 dicembre, in occasione della giornata internazionale dei migranti, un quadro drammatico della manodopera a bassissimo costo immigrata nei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg) cioè Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi, Kuwait, Oman e Qatar.
Già nel 1995 Robert Fisk, probabilmente il più famoso corrispondente estero britannico, sull’Independent riportava casi come quello diFelixberta Pasco, cameriera filippina di 32 anni, corsa a chiedere aiuto alla propria ambasciata di Abu Dhabi dopo che il suo datore di lavoro l’aveva picchiata. Non si trattava di un caso isolato e non a tutte è andata “bene” come alla Pasco. L’ultima è morta. Si chiamava Khadija Kamel, era un’etiope poco più che ventenne, cameriera presso una famiglia a Dubai. Chiusa a chiave in uno stanzino per due mesi, torturata, denutrita, picchiata con un bastone dalla sua padrona e poi colpita da polmonite senza che le venisse prestato alcun soccorso. È morta così, l’autunno scorso, l’ennesima schiava moderna del Golfo Persico. La sua padrona, caso più unico che raro, è stata condannata a una pena esemplare: 15 anni di carcere, più tre per il marito, accusato di favoreggiamento. In una regione che incarcera e condanna a morte frotte di collaboratrici domestiche immigrate, colpevoli di essersi ribellate agli abusi e archivia le accuse mosse verso i propri cittadini, la condanna di un datore di lavoro rappresenta un barlume di speranza. Ma la strada per il pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori e di quelli umani è ancora lunga. “Sono milioni questi migranti e hanno zero diritti: spesso vengono uccisi o si suicidano” ha spiegato Human Rights Watch (Hwr) tracciando lo scorso 18 dicembre, in occasione della giornata internazionale dei migranti, un quadro drammatico della manodopera a bassissimo costo immigrata nei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg) cioè Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi, Kuwait, Oman e Qatar.
Le ultime stime complessive parlano di quasi 18 milioni di lavoratori immigrati nel Ccg, su una popolazione totale di circa 42 milioni. In Qatar, la cui forza lavoro nel 2008 era pari a 1,3 milioni di persone, il 95 per cento era straniero.Provengono quasi tutti dall’Asia, in particolare da India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia e Filippine. A loro si aggiungono quelli provenienti dal Corno d’Africa, soprattutto dall’Etiopia. L’esercito di questi nuovi schiavi immigrati costituisce l’asse sul quale negli ultimi 30 anni è stata costruita la ricchezza dei paesi del Ccg. Nazioni desertiche e ricchissime, che siedono su immensi giacimenti di petrolio e che hanno visto creare intere città, infrastrutture e servizi da una manodopera sottopagata legata indissolubilmente al proprio datore di lavoro dalla Kafala, un sistema di reclutamento e garanzia che assomiglia pericolosamente all’acquisizione di uno schiavo. Di fatto un ufficio di collocamento nel paese d’origine trova un datore di lavoro disposto a sponsorizzare il lavoratore immigrato, che da quel momento non può cambiare posto di lavoro per tutta la durata del contratto.
Sono anni che Human Rights Watch snocciola report con le cifre della nuova schiavitù e con le storie delle vittime, in particolare delle collaboratrici domestiche. La maggior parte delle donne è impiegata presso le famiglie locali dove cucina, pulisce la casa e spesso crescere i figli della famiglia presso cui lavora, ricevendo in cambio vitto, alloggio e uno stipendio sufficiente per mantenere una famiglia nel paese d’origine. “La realtà, però, è diversa – ha spiegato Hwr – e si materializza con il sequestro del passaporto all’arrivo, l’impossibilità di cambiare lavoro senza il consenso del datore di lavoro, orari impossibili e nessun riposo settimanale”. Nelle case del Golfo, per via della Kafala, si consumano così innumerevoli violenze ai danni delle domestiche accusate di “lamentarsi per il troppo lavoro”, oppure di “urlare contro i bambini” o semplicemente di chiedere più diritti. Eclatante è stata la storia di una cingalese, bruciata su collo, viso e braccia nel 2009 dalla sua padrona per aver rotto un piatto. Dell’agosto 2010 è invece il caso di Lahanda Purage Ariyawathie, rimpatriata a Colombo dopo essere stata alle dipendenze di una famiglia saudita: i medici le hanno rimosso dal corpo 24 tra aghi e chiodi dai 2 ai 5 centimetri che il suo “padrone” le aveva conficcato nel corpo per essersi lamentata delle troppe mansioni domestiche.
Non è raro che le vittime di violenze impazziscano fino a togliersi la vita. Il suicidio di una donna nepalese, vittima di abusi sessuali in Kuwait, ha provocato il divieto, da parte delle autorità di Kathmandu, di emigrazione nei paesi del Ccg per tutte le sue cittadine dal 1998 al 2010. L’ultimo caso di suicidio riguarda invece il Libano dove nel marzo del 2012 l’etiope Alem Dechasa si è impiccata nell’ospedale psichiatrico di Beirut nel quale era stata rinchiusa dopo essere stata filmata mentre veniva picchiata e trascinata in auto dal suo padrone. Situazioni inumane e quando va bene “le paghe sono da fame, spesso trattenute dal padrone a tempo indeterminato, proprio nelle nazioni che vantano alcuni tra i Pil più alti del mondo” ha spiegato Hwr. Si va dai 100 ai 400 dollari al mese, e il prezzo varia a seconda del Paese di destinazione e quello di provenienza.
Ma è possibile ribellarsi? Si a rischio di incappare in un destino che può andare dallo stupro, al carcere fino alla pena di morte. Scappare senza il permesso del padrone può implicare automaticamente una condanna, in quanto si violano le clausole della Kafala che di fatto stabilisce la proprietà del datore di lavoro sull’immigrato. Le cose si complicano poi nei paesi più intransigenti dal punto di vista religioso, come l’Arabia Saudita, dove alle donne è vietato uscire di casa senza un uomo: lì la muttawi’a, la polizia incaricata di sorvegliare il rispetto della Shari’a ha condannato decine di donne immigrate, colpevoli di essere state pescate a chiacchierare con un connazionale o di essere andate da sole in commissariato per denunciare un abuso. In Arabia Saudita, come negli Emirati, vige poi la pena capitale e nel 2012 Ruyati Binti Sapubi, 54enne originaria di Giava, era stata decapitata per aver ucciso il proprio datore di lavorio per legittima difesa.
Ma fuori dalle mura domestiche la situazione non sembra migliore. “Sarà un Mondiale costruito sullo sfruttamento e sull’abuso della forza lavoro migrante” è scritto nel rapporto del 2013 di Hrw che riguarda i Mondiali di Calcio 2022 in Qatar. Secondo l’associazione umanitaria, la forza lavoro, soprattutto manovali nei cantieri, proveniente da India, Nepal, Pakistan e altri paesi del sudest asiatico, “sopravvive in Qatar in condizioni prossime alla schiavitù: con paghe basse, ammassata in bidonville costruite ad uopo, senza acqua corrente e ventilazione, e costretta a lavorare senza le minime tutele di sicurezza né assistenza sanitaria”. “In Qatar il traffico di esseri umani e le condizioni di lavoro prossime alla schiavitù sono un problema gravissimo. Mancano i requisiti minimi richiesti dalla Fifa per l’assegnazione di una manifestazione” scrive l’associazione. Mentre Sarah Burrow, portavoce del sindacato internazionale ITUC, utilizza senza remore il termine “schiavitù moderna” e prevede che: “Saranno più i migranti morti sul lavoro nella costruzione degli stadi che non i giocatori che parteciperanno al Mondiale”.
Ora Hrw ha chiesto all’Associazione per la cooperazione regionale del sud-est asiatico(Saarc) di fare pressione sui propri governi per costringere i paesi del Ccg a rispettare i diritti e la dignità dei lavoratori migranti: dalla discriminazione all’impossibilità di formare un sindacato di categoria, dagli orari di lavoro agli abusi subiti. “Tutto deve essere riscritto, a cominciare dalla Kafala” che, ha dichiarato Brad Adams, responsabile dell’organizzazione per l’Asia di Hwr, “deve essere riformata per permettere ai lavoratori di cambiare impiego o rientrare nei propri paesi anche senza il permesso del datore di lavoro. I paesi del Golfo dovrebbe riconoscere il ruolo cruciale dei lavoratori migranti nelle loro economie e adottare delle misure perché i loro diritti vengano pienamente garantiti”.
Alessandro Graziadei
Fonte: Unimondo.org
Ti è piaciuto l'articolo? Sostienici con un "Mi Piace" qui sotto nella nostra pagina Facebook