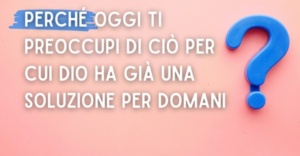Il Sahel è un’area dell’Africa che potrebbe uscire dalla crisi alimentare. Eppure ci resta. I raccolti sono andati bene. Le piogge sono tornate, dopo la terribile e lunga siccità iniziata nel 2011 di cui l’Europa ripiegata sui suoi mali non s’è quasi accorta. Nonostante ciò, i prezzi dei cerali oggi sono dal 40 al 70% più cari rispetto al 2009. Il cibo c’è ma le famiglie non possono più permettersi di comprarlo. Quando il granaio di casa si svuoterà, sarà di nuovo fame.
Se l’annata sarà buona, 230 mila bambini moriranno nel Sahel a causa della malnutrizione, dice nudo e crudo uno degli ultimi report dell’Unicef. La mortalità infantile è uno degli indicatori che illuminano la situazione paradossale che sta vivendo questa regione, dove 18 milioni di persone sono state colpite nel 2011 e 2012 da una grave crisi alimentare che ha attraversato la fascia dal Senegal al Ciad, passando per Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria e il nord Camerun. Il ritorno delle piogge dovrebbe decretare la fine dell’emergenza, eppure il numero dei bambini malnutriti nel 2013 sarà addirittura più alto che nel 2012: un milione e 400 rispetto a un milione.
Per capirci qualcosa bisogna riavvolgere il nastro fino al 2008, anno della penultima carestia. Sì perché le crisi, in questa regione a sud del Sahara, si susseguono a ritmo più serrato rispetto al passato: “Se prima ce n’era una ogni decennio, dal 2000 ne abbiamo già vissute tre” dice da Ouagadougou Marco Alban, cooperante di lungo corso dell’Lvia, ong che dal 1972 opera in Burkina Faso. “Il peggio si è verificato nel 2008-2009” continua, “quando la crisi alimentare e, in concomitanza, la speculazione sui cereali fatta a livello internazionale ha fatto lievitare i prezzi di grano, mais, riso e miglio”. Per il Sahel è stato uno shock mai più riassorbito. “È saltato un equilibrio” spiega Alban. “Qui tutti si nutrono di cereali e il Burkina come molti Paesi dell’area ricorre all’importazione, perché la produzione non è sufficiente a coprire il fabbisogno della popolazione. Il risultato è che i beni di prima necessità sono diventati carissimi: oggi al mercato il miglio rosso costa il doppio rispetto al 2009. Non si tratta più solo di un problema di carestia, il cibo spesso c’è ma la maggior parte delle famiglie non può permettersi di comprarlo”.
La speculazione sul cibo non è solo un fenomeno internazionale governato da grandi e potenti lobbies. “C’è anche una speculazione a livello nazionale e locale” avvisa Alban. “Durante la stagione del raccolto alcuni commercianti burkinabè stoccano i cereali, per poi rimetterli sul mercato al doppio del prezzo nel periodo più duro che va da marzo a maggio, quando le riserve famigliari e dei piccoli agricoltori si vanno esaurendo”. La popolazione del Burkina Faso è per l’80% dedita all’agricoltura di sussistenza, vale a dire che quasi ogni famiglia coltiva il proprio appezzamento di terreno che però non basta a coprire il fabbisogno di un anno intero. “Quest’anno il governo ha introdotto delle misure per calmierare immettendo sul mercato determinate quantità di cereali a metà prezzo” prosegue Alban, “ma è riuscito a farlo solo grazie al contributo dei donatori e della cooperazione internazionale, che ha coperto il 60% dei costi dell’operazione”. L’intervento dei governi locali funziona per periodi limitati e dipende dalla disponibilità di risorse, in definitiva dagli aiuti. Ma il problema è strutturale e rimane.
Anche la Fao di fronte al paradosso saheliano ha smesso di ripetere come un mantra che il problema è produrre di più. Laddove la produzione c’è, sta comunque aumentando la povertà. Da una crisi alimentare all’altra (il Sahel ne ha vissute almeno tre importanti, nel 2005, 2008 e 2011) c’è poco tempo per riprendersi, le famiglie consumano i risparmi e si indebitano, e i prezzi dei beni alimentari si sono stabilizzati a livelli alti, spesso più legati a dinamiche finanziarie internazionali che a una maggiore o minore produzione. A contribuire sono ovviamente anche altri fattori, come la degradazione del suolo, l’avanzare del deserto e i periodi di siccità sempre più lunghi. “Sta piovendo sempre meno” afferma Alban. “Se negli scorsi decenni la stagione della pioggia durava da aprile a novembre e si riuscivano persino ad avere due raccolti, ora il tempo fertile si è ridotto da giugno a settembre e va già bene se si riesce a fare un raccolto”. Che si tratti del cambiamento climatico o di normali cicli che si sono sempre verificati poco importa. Di certo la cattiva gestione delle terre e lo sfruttamento avvenuto negli ultimi anni ha peggiorato la situazione. Eppure qualche misura ardita potrebbe essere messa in campo. Per esempio sovvenzionare il gas per uso domestico diminuendo i costi a carico delle famiglie frenerebbe il taglio degli alberi, in un Paese dove è comune usare la legna per cucinare. Cucinare gli alimenti prodotti in loco permetterebbe alla popolazione di essere meno ostaggio delle borse e dei prezzi decisi altrove: “Le baguette che si trovano ovunque sono fatte con grano importato persino dagli Usa o dall’Europa, visto che il Paese non ne produce” racconta Alban. “Un altro paradosso è il latte in polvere, se ne importa per 20 milioni di euro l’anno in un Paese dove ogni famiglia ha almeno una capra o una mucca da cui mungere il latte”. Le ong insieme alle agenzie internazionali hanno una nuova parola d’ordine: “resilienza”.
Non si parla più di sviluppo né di emergenza ma di prevenire le crisi alimentari puntando per esempio su sementi più robuste e ricche di proteine, o di elaborare insieme al governo strategie di stoccaggio e politiche di contenimento dei prezzi.
Emanuela Citterio
Ti è piaciuto l'articolo? Sostienici con un "Mi Piace" qui sotto nella nostra pagina Facebook