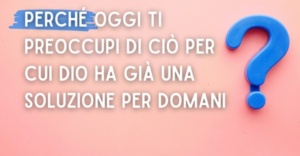Cfp, Its, apprendistato. È ora di mettere da parte «l’idea molto sessantottina per cui il pensiero intellettuale è più nobile che imparare un mestiere».
Cfp, Its, apprendistato. È ora di mettere da parte «l’idea molto sessantottina per cui il pensiero intellettuale è più nobile che imparare un mestiere».
Filippo Meneghello ha 24 anni e un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Agusta, azienda del gruppo Finmeccanica, lo ha assunto al termine di un percorso formativo a cui è approdato dopo aver capito che l’università non faceva per lui. Due anni di ingegneria dopo la formazione tecnica superiore, infatti, gli erano bastati. «Soffrivo della mancanza di attività pratica», racconta a Tempi. È in quel periodo che Filippo scopre l’esistenza dei cosiddetti Its, Istituti tecnici superiori che offrono una qualifica terziaria (cioè successiva al diploma di scuola secondaria superiore), ma di tipo non universitario.
In Italia ce ne sono 62 in tutto (più 2 in fase di startup) e sostanzialmente offrono ciò per cui era stata originariamente pensata la laurea triennale: una formazione legata al mondo del lavoro. Di fatto nelle università questo non accade, la maggioranza degli iscritti continua per i due anni successivi al triennio e chi non si sente tagliato per una formazione generalista rimane a piedi; ultimamente prigioniero di un pregiudizio che, fin dalla scuola dell’obbligo, vede nella formazione teorica e liceale un percorso di serie A e in tutto ciò che è professionalizzante un addestramento di meno valore, destinato a “quelli che non ce la fanno”. «In questi ultimi anni qualcosa è cambiato», nota Emanuele Massagli, dottore di ricerca in Diritto delle relazioni di lavoro e presidente di Adapt, il centro studi sul lavoro fondato da Marco Biagi. «Si comincia a parlare di valorizzazione del lavoro e, complice la crisi, alcuni mestieri vengono rivalutati. Però il sostrato culturale resta lo stesso».
Un esempio significativo si è avuto qualche mese fa, quando il governo sbloccava alcune attese risorse per la scuola, con il decreto Carrozza in cui tra l’altro si ribadiva esplicitamente l’importanza di «riconoscere la valenza formativa del lavoro». Peccato che poi i 15 milioni per combattere la dispersione scolastica fossero sostanzialmente destinati a coprire i costi per tenere le scuole aperte di pomeriggio. Ma chi la scuola l’abbandona perché non fa per lui, cosa se ne fa delle aule aperte più a lungo?
 «Io credo – riprende Massagli – che in Italia scontiamo un pregiudizio nato negli anni Settanta, cioè dopo il boom economico partito negli anni Cinquanta e trainato da un’istruzione tecnica di livello, per cui eravamo famosi anche a livello internazionale». Sono quelli infatti gli anni in cui periti e diplomati tecnici entrano in azienda come dipendenti e dopo qualche anno si mettono in proprio. Una volta raggiunta una certa solidità dal punto di vista economico, gli anni Settanta vedono la rivalutazione di un modello gentiliano di scuola: da una parte la cultura classica liceale pensata per la classe dirigente, quella di serie A. Dall’altra parte la formazione professionale (che ai tempi non era neppure di uguale diritto), destinata a chi dirigente non sarebbe mai stato e aveva necessità di iniziare presto a lavorare.
«Io credo – riprende Massagli – che in Italia scontiamo un pregiudizio nato negli anni Settanta, cioè dopo il boom economico partito negli anni Cinquanta e trainato da un’istruzione tecnica di livello, per cui eravamo famosi anche a livello internazionale». Sono quelli infatti gli anni in cui periti e diplomati tecnici entrano in azienda come dipendenti e dopo qualche anno si mettono in proprio. Una volta raggiunta una certa solidità dal punto di vista economico, gli anni Settanta vedono la rivalutazione di un modello gentiliano di scuola: da una parte la cultura classica liceale pensata per la classe dirigente, quella di serie A. Dall’altra parte la formazione professionale (che ai tempi non era neppure di uguale diritto), destinata a chi dirigente non sarebbe mai stato e aveva necessità di iniziare presto a lavorare.
«Alla base – riprende Massagli – c’è l’idea molto sessantottina per cui il pensiero intellettuale è più nobile della pratica manuale. Perché se il lavoro è inteso o come uno sfruttamento del capitale sulla persona, o come una fatica inevitabile per arrivare a fine mese (e non, come scriveva Giovanni Paolo II nella Laborem Exercens, come possibilità di realizzazione della persona e partecipazione alla società), allora è naturale rinviare il più possibile il contatto dei ragazzi con un’esperienza considerata tanto alienante. Non c’è da stupirsi dunque se la fantasia imprenditoriale degli anni Cinquanta e Sessanta non c’è più stata. L’Italia rimane un paese di piccola e media impresa, ma i dati europei dicono che i giovani studenti italiani hanno meno sogni imprenditoriali dei loro coetanei del Nord Europa. E questo per un paese come il nostro è un dato impressionante».
Oggi in Italia, secondo dati Isfol, quasi il 60 per cento dei giovani tra i 18 e i 24 anni che ha frequentato un percorso di Istruzione e Formazione Professionale ha un impiego a tre anni dalla qualifica e immediatamente dopo aver terminato il percorso lavora il 50 per cento degli allievi. I primi risultati dei già citati Its non sono meno incoraggianti. Le statistiche del Miur riferite ai primi 825 diplomati (250 ragazzi raggiungeranno il titolo entro fine anno), evidenziano che gli occupati sono 470, il 57 per cento del totale. Con casi eccellenti come l’Its Accademia marina mercantile di Genova, dove tutti i 65 diplomati hanno trovato un lavoro. Sfiora il 100 per cento pure l’Its della meccanica di Vicenza (21 dei 22 diplomati sono occupati).
Numeri che fanno riflettere dal momento che in Italia meno di due ragazzi su dieci lavorano: il tasso di occupazione tra i giovani nella fascia 15-24 anni è sceso al 16,1 per cento. «La Germania è l’unico Stato occidentale che durante la crisi ha visto crescere l’occupazione giovanile. Come si può pensare che l’impianto scolastico formativo non c’entri nulla con questi risultati? Possibile che quei ragazzi che in Italia subito dopo la qualifica di formazione professionale trovano lavoro siano tutti particolarmente fortunati?», si domanda Massagli. «Di sicuro la Germania non ha avuto i nostri anni Settanta con la conseguente opera di sottovalutazione della valenza educativa e formativa del lavoro. Questo non significa, tuttavia, che il loro modello si possa riprodurre tale quale in Italia. Il punto, piuttosto, è quello di conciliare l’ottima formazione generalista italiana con la possibilità di imparare un mestiere, perché non si può arrivare a trent’anni con tanta capacità critica ma senza saper avvitare un bullone».
Fonte: http://www.tempi.it/
Ti è piaciuto l'articolo? Sostienici con un "Mi Piace" qui sotto nella nostra pagina Facebook